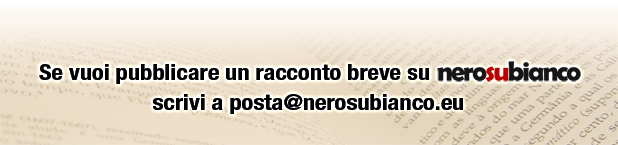Treccine | di Iole Palumbo
Avevo i capelli identici a quelli del mio papà. Me ne ero accorta dai ricci che andavano ognuno in una direzione diversa che quello sconosciuto del ritratto, malamente nascosto nel portafogli di mia madre, era lui. La nonna con la quale ero cresciuta aveva provato a domare la mia chioma con cerchietti, mollette e pinzette di ogni tipo, ma sempre con molta fatica e dolore. I nodi si ribellavano al pettine e i boccoli rifiutavano il carcere degli elastici. La vittoria finale era riuscita a riportarla solo mia madre quando l’avevo raggiunta in Italia. In quattro e quattr’otto, con una leggerezza a cui la mia testa era così poco avvezza, aveva definitivamente imprigionato quelle ciocche, chiudendole in treccine tutte uguali, impreziosite da fili coloratissimi.
Solo all’asilo avevo scoperto che c’erano bimbe con le code di cavallo morbide e lisce, che ondulavano ad ogni movimento con una tale dolcezza da far sembrare il mio cespuglio un rovo di spine. Avrei dato via la mia unica bambola col braccio rotto per avere anche solo per un giorno una coda così! Eppure per chissà quale strana ragione in estate le ragazze italiane impazzivano per le treccine come le mie. Mia madre, che era espertissima, si era messa a procurarsi da vivere vendendo la sua arte sulle spiagge. Gli affari andavano a gonfie vele, c’era solo un piccolo problema: non sapeva dove sistemarmi mentre lavorava.
Così partivamo assieme da una scogliera con una piccola lingua di sabbia e continuavamo lungo tutto il litorale per otto chilometri, il cammino durava tutto il giorno. Mi piaceva fare colazione al bar e indossare il mio pareo nuovo, mettere i piedi nell’acqua gelata e affondare nell’arena fino alle caviglie, ma appena il sole cominciava ad alzarsi per irradiare la costa perpendicolarmente, sentivo le gambe diventare dei pesi di piombo, la testa rovente e il respiro così pesante che naso e bocca assieme non trovavano ossigeno da nessuna parte. Odiavo mia madre che mi costringeva a trascinarmi con sempre maggiore fatica. Non di rado rimanevo indietro e lei si spazientiva. Più mi accasciavo più si allontanava, mi faceva ciao con la mano lasciandomi intendere che mi avrebbe abbandonata lì. Ora so che quello era l’unico modo per farmi ripartire, ma all’epoca immaginavo di essere catturata da sconosciuti che mi portavano chissà dove e facevo appello alle ultime forze che mi restavano. Invidiavo con cattiveria le bambine che giocavano sulla riva e ancora di più le signore che mi sorridevano dicendo: “che carina!”. Poi finalmente qualcuno ci fermava. Qualche cliente mi regalava un euro per il gelato. Settembre ci metteva tanto ad arrivare e io lo aspettavo come quel gelato che non facevo mai in tempo a comprare.
Alle medie ho detto addio alle mie treccine, la piastra è la mia inseparabile compagna e la coda di cavallo è l’acconciatura che mi contraddistingue anche ora che dormo in hotel e vado al ristorante tutti i weekend.
8 agosto 2020 – © Riproduzione riservata