La scala | di Ornella Cauteruccio
Sofia era stanca di tanta monotonia, di quell’ennesima estate, piatta e interminabile che si dipanava lenta tra il silenzio assordante della campagna e i pomeriggi sonnolenti di giochi oramai privi di qualsiasi attrattiva. Si vestì in fretta. Doveva dare una buona impressione, quindi indossò il vestitino più bello, quello bianco, oltretutto abbastanza lungo per nascondere lo scempio delle sue ginocchia e donarle la parvenza di una signorinella delicata e a modo. Era arrivato il momento di provare a realizzare il suo sogno segreto. Ora o mai più.
Quando si trovò davanti al portone, severo come la pietra che ne disegnava l’arcata e pauroso come i due leoni che ne reggevano i battenti fra le zanne, indugiò intimorita prima di osare varcarne la soglia. L’androne era buio e umido, nonostante la splendida giornata di sole. Rabbrividì, mentre gli occhi si abituavano piano a quella oscurità inaspettata e quando, dalle tenebre, si stagliò nitida la sagoma della scala, alta e minacciosa, Sofia arretrò spaventata.
Lo stretto vestibolo presentava due porte laterali, malandate e ricoperte di polvere, chiuse da quando le stanze non venivano più usate come aule scolastiche di fortuna per i bambini del borgo. Non c’era la corrente elettrica e nessuna apertura che illuminasse i gradini enormi in pietra che si ergevano davanti a lei: l’unico rivolo di luce proveniva dall’esterno, alle sue spalle, regalando all’oscurità una danza luminosa e leggera di pulviscolo dorato. Salì a fatica, quasi arrampicandosi sui gradini troppo grandi per il suo fisico minuto. Alla fine della prima rampa, la raggiunse un suono ovattato, una melodia antica e ammaliante. Sofia non era più stanca, né spaventata mentre apriva piano la porta, in cima alle scale, pronta ad afferrare il suo sogno segreto.
Adesso la melodia era divenuta corpo: si era tramutata in carne, sangue e passione, la stessa passione che la divorava giorno e notte da quando l’aveva sentita per la prima volta, tornando da scuola; da quando, per la prima volta, aveva conosciuto la Bellezza. Tutto intorno a lei si trasformava, persino il mare, muto compagno dei suoi giorni, sembrava parlarle. Attraverso la musica aveva scoperto l’esistenza di altri mondi possibili e lei si struggeva dal desiderio di esplorarli.
Lo stanzone appariva enorme nella sua nudità: l’unico arredo era il vecchio pianoforte a coda che, a dispetto degli anni, era ancora di un’eleganza struggente, al pari di Marta. La sua figura esile aveva qualcosa di irreale e tragico al tempo stesso: nel totale abbandono alla musica trasudava sensualità, forza, mista a fragilità, e un senso antico di dolore. Quando si accorse della presenza di Sofia, smise di colpo di suonare, lasciando a mezz’aria echi di note irrisolte. Nel silenzio irreale ed improvviso i loro sguardi si incontrarono per la prima volta, con il loro rispettivo carico di stupore e di emozione. La richiesta di Sofia esplose dentro la stanza con la medesima carica deflagrante di una bomba ad orologeria: “Voglio imparare a suonare il pianoforte come te. Lo sento sempre e dappertutto, anche di notte. Ti prego, insegnami!”.
Era un appello disperato, che non lasciava scampo. Marta rivide in quella ragazzina ossuta, nei suoi occhi penetranti, in quel corpo tremante e teso come la corda di un violino, la sua stessa inappellabile testardaggine e, in quell’istante, riaffiorarono tutte le battaglie combattute a denti stretti, le dolorose sconfitte, la fuga da quel posto maledetto da Dio e dagli uomini, e il ritorno sulle ali del disinganno e della vergogna. La vergogna della famiglia, per il frutto della sua ribellione che aveva i suoi stessi occhi scuri e beveva avidamente dal suo seno come se volesse prosciugarne l’intera esistenza e che doveva rimanere nascosta agli occhi del mondo; la vergogna che la costringevano a provare gli sguardi indagatori e accusatori della gente; la vergogna che provava per non essere la donna libera che avrebbe voluto diventare, per aver fallito, per non aver mantenuto le promesse fatte a sé stessa.
Oramai si nutriva soltanto di rabbia e di musica, e fu la rabbia a parlare per lei: “Piccola impertinente! Cosa vuoi saperne tu di musica? Sei ignorante come lo sono sicuramente i tuoi genitori, come lo sono tutti qui, in questo posto sperduto. Ti conviene tornare subito a casa e non dirò niente di quello che è successo!”.
Il suo tono, le sue parole, non lasciavano via di scampo. Sofia sentì franare il pavimento sotto i piedi e non riuscì a fare altro che scappare via, giù per quella scala orribile, correndo più velocemente che poté, mentre i singhiozzi le salivano ad ondate, sommergendola.
Mentre Marta tremava ancora di rabbia per l’audacia della bambina, il piccolo fagottino nella culletta accanto al pianoforte, il frutto della vergogna come la chiamava sua madre, incominciò piano a piangere. A sentire quel pianto sommesso, Marta si sentì invasa da un’enorme pietà, pietà verso quella neonata innocente, verso quella ragazzina ribelle e appassionata, ma soprattutto pietà verso sé stessa, per quello che era diventata, e allora, finalmente, capì.
Fu un attimo e si precipitò verso il balcone, vide Sofia che non aveva ancora svoltato l’angolo in fondo alla via: “Ragazzina!”, incominciò a chiamarla “non mi hai detto come ti chiami!”. Sofia si asciugò velocemente le lacrime e le rispose: “Mi chiamo Sofia, signorina”. “Torna domani alla stessa ora e porta con te un quadernetto e una matita. Cominceremo con un po’ di solfeggio. Per il resto, si vedrà”, e così dicendo, rientrò nella stanza, senza lasciarle modo di replicare.
Marta aveva capito che non era più tempo di provare vergogna, che era il momento di affrontare di nuovo la vita a testa alta, con dignità, perché c’erano altre battaglie da combattere: per sua figlia, per quella ragazzina sconosciuta e coraggiosa, per sé stessa… e stavolta ne sarebbe uscita vincitrice.
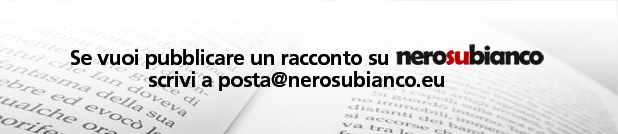
23 dicembre 2021 – © riproduzione riservata





