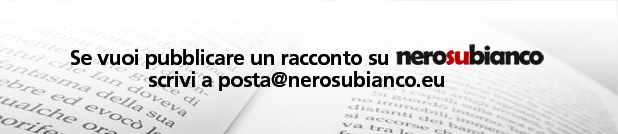Le conseguenze della notte | di Umberto Faenza
Era una di quelle notti, e facevo fatica a prender sonno. Meglio, a riprenderlo.
La mia insonnia non sorgeva dal principio: arrivava di soppiatto ad interrompere il riposo. E così fu anche quella volta.
Pensavo, pensavo, e ripensavo. Ponevo domande a chi non può più rispondere. Una pratica poco invidiabile: non ti lascia altro che una buona dose di vuoto.
Scrivere è l’illusione della vita eterna. Rimanere vivi finché qualcuno leggerà quello che hai scritto. Ma non è vero: sarò morto. Pavese è morto. Pasolini è morto. E la vita eterna è soltanto una questione di tempo.
Mi alzai, nonostante la stanchezza. Nonostante volessi anch’io, come Titta Di Girolamo, solamente una cosa: dormire. Mi avvicinai al mobile che stava di fianco al letto. C’era la foto di noi quattro, sorridenti insieme di una pace che c’eravamo concessi per un giorno di festa. La cornice si appoggiava su una pila di libri di cui lessi per l’ennesima volta i titoli. C’era ‘La luna’, c’era ‘La bella estate’, c’erano i racconti di mio padre. Riguardarci negli occhi fece riaffiorare in me la solita sensazione. Fallita ubiquità, consapevole impotenza.
Storsi il naso, e me ne andai così alla finestra, spostando la tenda per guardare fuori. Da qualche anno a questa parte il mio sguardo era volto all’insù, e non era un caso. Stelle abbastanza vicine o abbastanza luminose riuscivano a far arrivare la loro luce ai miei occhi, punteggiando quel cielo che leggerissimo stendeva la sua pelle sulla nostra. Pensai al genio.
Quattro secoli prima, un uomo chiamato Galileo Galilei aveva preso un modello olandese di cannocchiale e aveva pensato bene di migliorarlo. Per prima cosa, lo aveva portato al Doge, mostrandogli le potenzialità militari dello strumento, e ricevendo così un aumento. Poi, con un gesto tanto semplice, naturale, quanto straordinario, lo aveva – pensate un po’ – volto all’insù. La visione dell’universo era destinata a cambiare per sempre.
Galileo era sì un genio. Ma era anche un uomo, un essere umano, uno di noi.
Prima di scrivere il Sidereus era frustrato, sempre indaffarato, occupato da mille piccoli lavoretti che gli venivano commissionati, e che lui sentiva gli stessero togliendo del tempo prezioso. Aveva dentro qualcosa che non poteva più ignorare.
Galileo aveva visto che la Luna era un corpo tutt’altro che perfetto. Da miliardi di anni ci mostrava la sua faccia, le sue cicatrici, la sua storia. La sua imperfezione gridava: vi appartengo. E viceversa.
Galileo aveva poi visto dei corpi luminosi intorno a Giove: prima tre, poi due, poi di nuovo tre, e poi ancora due, e poi addirittura quattro! Li aveva annotati come stelle. Ma ben presto capì che ciò che aveva visto doveva essere qualcosa di straordinario. Galileo aveva scoperto le lune maggiori di Giove, oggi anche dette, appunto, galileiane.
Nel raccogliere le sue scoperte, Galileo decise di aprire il suo Nuncius non solo con la descrizione dello strumento che aveva usato, ma soprattutto con un invito: quello di procurarsene in qualche modo uno simile, e di guardare con i propri occhi.
Quattro secoli dopo, puntando i miei al cielo, io sapevo queste cose perché le avevo lette. Perchè nelle rigide notti invernali, quell’uomo aveva scritto, appuntato, disegnato. Ed aveva fremuto, per anni, dal bisogno che aveva di esprimere ciò che aveva visto.
Non osai paragonarmi a lui, ma se c’era almeno una cosa in comune tra noi due, quella era il bisogno. Il bisogno, di essere umano, di provare a fermare il tempo, di riuscire ad incidere la vita negli spazi, di discutere con la morte su di un foglio.
E poi quel cielo, che di certo doveva essere meno stellato del suo, ma comunque lo stesso. E che con garbo mi guidò nel realizzare che a volte è poca cosa quella linea che divide, quattrocent’anni, o chi è già morto, o chi ancor vive. Che poi alla fine le parole arrivano da sole a chi devono arrivare. Attraverso ere, atomi, bagliori. E che forse vale anche la pena, se non si può più chiedere, almeno di parlare, almeno di scrivere, almeno di pensare.
Perciò, lasciando la finestra, mi misi a sedere, e scrissi:
Padre, ho passato molte notti ad osservare il cielo.
Venere è un punto fermo. Mi ricorda che anch’io la osservo da una luce della sera.
Orione, con la sua cintura, mi dà un senso di ordine.
La Luna, un senso di appartenenza.
Padre, ho passato molte notti ad osservare lo schiarirsi della volta,
al di là di nubi che vanno e che vengono, che si trasformano,
che fuggono via veloci se il vento è abbastanza forte.
Nonostante questo, padre, io non ti ho trovato.
Neanche quando le stelle parevano stessero per appoggiarmisi addosso.
Neanche quando in un respiro di aria fresca ho messo piede su mondi sconosciuti.
Neanche quando ho immaginato noi seduti sull’orlo del buco nero.
Padre, ho passato molte notti a cercarti con lo sguardo.
Nonostante questo, padre, io non ti ho trovato.
Ho scoperto, però, la strada di casa.
16 aprile 2021 – © riproduzione riservata