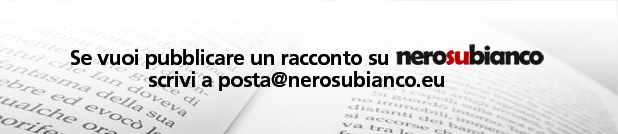La sconfitta | di Iole Palumbo
Era stata mia nonna a raccontarmi della fatica che faceva a ricordare i nomi per intero dei suoi conoscenti. Alcuni li aveva accompagnati fino al camposanto identificandoli solo grazie al soprannome, che veniva riportato anche sul manifesto di morte pur di permettere a tutti di capire chi fosse venuto a mancare. Era così naturale usare l’appellativo in luogo del nome di battesimo che nessuno se ne risentiva. Anzi lei era pronta a scommettere che in casa neppure i familiari rompessero la tradizione.
Storia o abitudini, a me poco interessava. Se pensavo a mia nonna da piccola mi sembrava di tornare alla preistoria. Oggi tutto era diverso, i soprannomi ce li avevano solo gli sfigati. E io ero uno sfigato. Il mio nome era così comune che, per spiegare chi fossi, tutti dicevano: “l’orfano”. Avevo le gambe corte e le guance rotonde, in testa un nido di riccioli biondi che da quando si erano allungati erano cresciuti in circonferenza in modo esponenziale. Se mi avessero riconosciuto per queste caratteristiche avrei anche sorriso, ma orfano mi rimbombava fin nella pancia e lì rimaneva. In quei momenti, neanche l’hot dog che trasborda maionese sotto i miei denti riusciva a farmi gola.
L’ultimo pomeriggio in compagnia di mio padre era stato una domenica. Le finestre del salone erano spalancate e io avevo dovuto accendere il televisore in camera per vedere l’ultima serie dei Pokemon perché la luce in sala era troppo forte. Il ramo del pesco nel giardino aveva raggiunto il davanzale e non riuscivo a capire come avesse fatto, la gemma che vi stava sopra, a squarciare la corteccia per liberarsi. Tra pochi giorni avrebbe sancito la sua vittoria definitiva ed effimera mostrando i petali appena visibili. Avrei voluto fare un paio di canestri col pallone nuovo, era la giornata ideale, ma non ero riuscito a chiederlo a lui. Da qualche tempo non toglieva il pigiama e ogni volta che si alzava dalla poltrona o dalla sedia temporeggiava un quarto d’ora prima di cominciare a camminare. Capii che aveva voglia di stare con me e solo questo gli aveva dato la forza di tirare fuori dal cassetto le carte per una scopa. Finimmo a litigare perché io, che avevo da poco cominciato a fare le addizioni, mi scocciavo di contare e prendevo solo le coppie. Il giorno dopo abbandonò la nostra casa e non tornò più.
Per tutti diventai il bambino “orfano” di papà. Se non facevo i compiti o se fingevo di aver lasciato il libro a casa nessuno me ne faceva pagare le conseguenze. Durante le verifiche in classe, se volava un bigliettino sul mio banco, le maestre fingevano di essere impegnate in altre faccende. Anche a casa le regole erano cambiate: dopo pranzo mi crogiolavo sul divano passando dai fumetti alla play senza vincoli di orario. Quei pomeriggi erano pieni del vuoto della mia esistenza. La testa si annientava nelle luci e nei suoni del videogioco. Il suo viso cominciava a sbiadire nei miei ricordi. I contorni della faccia non erano più nitidi, rivedevo le sue occhiaie livide che nascondevano l’iride incavato, sembravano due enormi macchie che occupavano gran parte dello spazio a disposizione. E ogni volta che ci pensavo mi comparivano più viola e più grandi. Ne ero terrorizzato. Perché quell’immagine scomparisse dalla mia mente, non mi rimaneva altro da fare che lottare contro di essa, allontanarla il più possibile.
Ai miei compagni il fatto che avessi i loro stessi voti senza far nulla non andava giù. Ero diventato un privilegiato, mi guardavano di sottecchi e mi invitavano ai compleanni solo perché costretti dai genitori. Lungi dal rammaricarmi, preferivo la loro sincerità al compatirmi degli adulti.
Aspettai l’inizio delle superiori con impazienza, pensavo che nella nuova città non avrei avuto un soprannome. Ero convinto che bastasse una nuova scuola ad alleggerire quel masso che avevo nello stomaco. Mi ritrovai, invece, una mattina, da solo, avanti ad uno schermo, le voci che ne uscivano erano un enorme frastuono. Pretendevano che imparassi ad usare codici, piattaforme, classi virtuali e moduli di verifiche. Mentre ciò che volevo era solo presentarmi ai miei compagni col mio vero nome. Mi avevano creato un’identità digitale, peggiore di quella che avevo prima. Decisi allora di arrestare il sistema prima ancora di riavviarlo.
Con un click mi liberai da quella prigione. Me ne andai a zonzo contento perché a quell’ora non correvo rischi, i miei coetanei erano a casa a fingere di fare la dad. La zona rossa, insperatamente, mi aveva restituito la possibilità di vagare in santa pace. Da quando mio padre non c’era più evitavo di percorrere le strade dove ero nato perché gli sguardi dei miei conoscenti mi colpivano come fendenti, li sentivo arrivare alle spalle ogni volta che mi giravo. Ma quella mattina mi trovai difronte due occhi spudorati che mi scrutavano senza compassione. In essi rividi me stesso e come ero diventato. In silenzio, la mia vecchia maestra mi urlò la sua delusione. In quel preciso momento io e lei capimmo di aver perso.
27 marzo 2021 – © riproduzione riservata