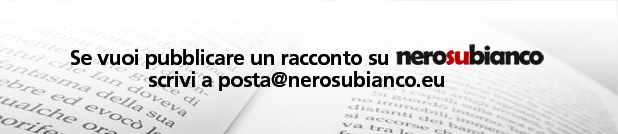Il sole caldo del pomeriggio
[di Umberto Faenza]
Per buona parte della settimana, ad un certo punto del giorno, il mio dito di bambino s’incontrava col pulsante di quel citofono. L’ora doveva essere piuttosto regolare, nonché quella del pranzo. Il pulsante era di quelli da premere fino in fondo, e per cui la durata del suono corrispondeva esattamente al tempo in cui il dito restava pigiato. Capitava a volte che questo ti scappasse, e il risultato era un suono rapido, che sapeva di sbaglio, o di scherzo, e che perciò ti costringeva a premere di nuovo, anche al costo di sembrare insistente. Serviva però a confermare l’intento. Non so dire, in tutta onestà, se queste cose le pensassi davvero in quei momenti. Però l’istinto, dopo un secondo di esitazione, mi portava sempre a premere ancora.
Quegli attimi vivono nei miei ricordi accompagnati da una luce solare, calda nel colore. Ma di fatto questa mia ricostruzione non può che essere irreale, statisticamente perlomeno, frutto del mio associare l’infanzia, la preadolescenza, ad un periodo tutto sommato spensierato, privo di nuvole.
A volte bastava un “io” per far sì che il portone si aprisse, e a volte anche meno. Così, zaino in spalla, entravo in quell’antro che sapeva sempre di fresco quando fuori c’era afa, e di protetto e asciutto quando invece fuori regnavano freddo e maltempo. Una prima piccola rampa di scale mi portava davanti alle cassette della posta, ognuna coi suoi cognomi stampati sulle targhe, di persone ognuna con la propria vita, che io giocavo ad immaginare perché non le conoscevo.
C’era una cosa, arrivati a quel punto, che riusciva davvero a cambiare la mia giornata di bambino: era l’odore di fritto. Talvolta il portone se ne impregnava e le mie narici poi facevano il resto, in un lampo di speranza ed entusiasmo con cui salivo le scale in tempi record.
Ma non sempre andava bene; d’altronde in quel palazzo non ci abitava soltanto mia nonna. La conferma arrivava solo mettendo piede in casa, spingendo la porta che avevo sentito aprirsi già mentre ero sulle scale. Bastava un attimo a capire se stesse accadendo per davvero. Perché quando l’intuizione era giusta, il profumo mi avvolgeva, inconfondibile, forte, ma buonissimo.
Lasciato lo zaino, ad incontrarmi era quasi sempre mia sorella, spesso i miei cugini, e poi mia nonna. Era lei che mi dava la notizia, la garanzia finale, quando andavo a salutarla in cucina, porta rigorosamente chiusa per la frittura. Sul tavolo i panetti, alcuni lavorati, e nell’olio, sfrigolanti, loro: le pizze fritte.
Così a tavola, tutti insieme, si godeva di questa pietanza dal sapore incredibile, e capace di lasciare anche perplessi – questo non da bambini, ma certamente oggi, e in positivo –, immaginando la geniale intuizione per cui qualcuno, ad un certo punto, pensò di cucinarla per la prima volta.
Erano più una enorme pazienza e uno sconfinato amore quelli che invece portavano mia nonna a farci da mangiare ogni giorno: senza troppi fronzoli ma con una grande dote culinaria, lei compiva tra i gesti più essenziali per la nostra sopravvivenza di cuccioli di umano. Se sono qui a pensare, elaborare, a mettere queste parole una in fila all’altra, è anche perché qualcuno mi ha sfamato da bambino. E mi ha protetto, per quanto si possa, dalle intemperie.
Dopo mangiato arrivava il tempo dell’attesa. Nella cesta dei giocattoli gli ingredienti per creare un paio di mondi. Alle volte, invece, correvo da un lato all’altro della casa, avanti e indietro, in continuazione, immaginando di segnare il più memorabile dei gol. Per quello gli ingredienti che servivano erano ancora meno, sostanzialmente due: i miei piedi.
E poi ecco che il fischio gracchiante dell’arbitro fermava il gioco. Talora troppo rapido, e perciò si aspettava la conferma. Al secondo suono però era ufficiale: le squadre si fermavano e la porta si apriva. L’attesa stava per finire.
C’era un’altra cosa, infatti, arrivati a quel punto, in grado di cambiare la mia giornata di bambino: era il profumo di mia madre. Quello però era sicuro, perché lo sentivo abbracciandola sulla porta, mentre lasciava le sue borse di lavoro.
Ecco che arrivava anche il suo turno di mangiare, e si sedeva a tavola intanto che la casa s’acquietava. Mia nonna poi si accomodava lì di fianco, per prendersi il meritato riposo. E così si parlava, si guardava la tv, mentre io tornavo a giocare, a terra nel mio mondo. Alle mie spalle quelle due donne, complici sì per natura ma soprattutto per scelta, erano due madri disposte a sacrificare tutto per un istinto, un obiettivo: che quei momenti rimanessero nei miei ricordi accompagnati sempre da una luce calda. Difficile immaginare qualcosa di più forte.
La loro missione, si capisce, era una di quelle folli, statisticamente per lo meno, date le circostanze. Ma loro erano lì, a guardarmi le spalle, a mettermi il cibo nello stomaco, a provarci comunque.
E adesso lo so.
Com’è che si ringrazia per l’amore? Io non credo di potere. Ma se ora, tornando bambino, lì seduto sul pavimento, vedo il sole – caldo – che riflette sulle mattonelle, vuol dire che alla fine un po’ ce l’hanno fatta. Adesso lo sapranno.
E anche se la verità non è solita far sconti, né ritardi, e non li fece, io stavolta, qui, la lascio fuori. Perché non appartenga più al bambino: è cosa mia.
Perciò, quando l’orario si faceva del meriggio, quello primo, con mia madre tornavamo verso casa. Nelle mie mani spesso un gioco, eroe di chissà quale mondo; alle mie spalle invece era una donna, eroina di quello più reale. Ed è così che poi la vita continuava, col sole a riscaldare anche se l’aria si straniva. E con la forza di una madre che mi proteggeva il cuore, mentre difendeva il suo.
11 dicembre 2021 – © riproduzione riservata